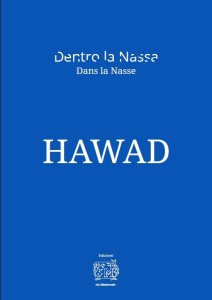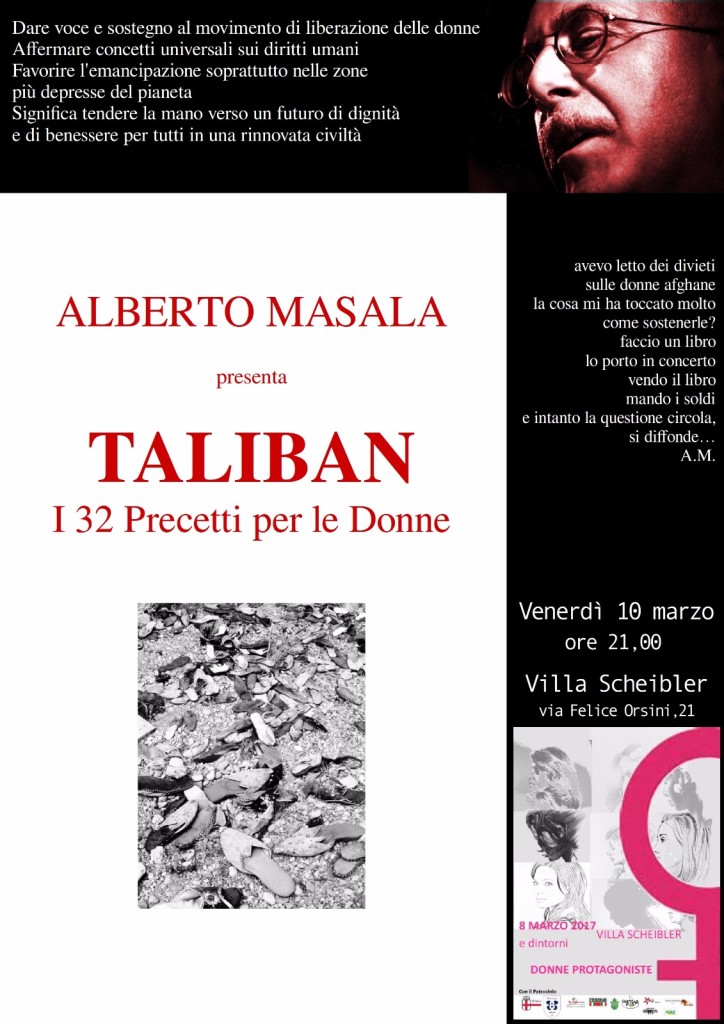Il poeta Raúl Zurita, durante le proteste in Cile. Foto da Twitter.
Il poeta Raúl Zurita, durante le proteste in Cile. Foto da Twitter.
*******************************************
Ho tradotto un pezzo apparso su “La Razón”. La situazione è drammatica. Polizia per le strade, torture, uccisioni, stupri e violenze di ogni genere per opporsi alla gente che sta manifestando. L’orrore riaffiora in un Cile che pare non aver memoria di quello già sofferto durante il regime di Pinochet.
Come allora, anche questa volta non li lasceremo soli. Ma dovremo agire prima che la catastrofe si compia, prima che l’orrore colpisca ancora.
La poesia, ancora una volta, dimostra di avere un compito insostituibile: ricondurre all’Umano gli Umani.
In questo sono a fianco di Raúl Zurita, grandissimo poeta ed amico, che da solo scende in strada con tutta la potenza della sua fragilità.
Di Raúl, in novembre, appariranno in Italia, per l’editore Valigie Rosse di Firenze, quattro meravigliosi poemi da me tradotti (link qui) con la supervisione e l’introduzione di Lorenzo Mari. Dunque, a presto.
Nel frattempo, Raúl, stiamo al tuo fianco. Con quell’amore che è la nostra forza indistruttibile. Il Cile non è solo.
*******************************************
Articolo di Julio Trujilloapparso su “La Razón” del 28 ottobre 2019
Un uomo per la strada solleva la bandiera del Cile. È tutti e nessuno, perché i poeti sono tutti e nessuno. È Raúl Zurita. Non è un vandalo né un criminale, non è stato convinto da nessuno o da niente: manifesta spontaneamente come spontanea è la combustione di gente che trabocca per le strade di Santiago.
L’immagine, che è muta, è eloquente e fragorosa: esprime stanchezza e disagio, affaticamento, ma anche un’enorme dignità e una bellezza commovente. È una persona, né più né meno, fragile nell’aspetto e potente in ciò che dice senza dirlo. È una crisi, e la buona poesia è sempre in crisi, è resistenza, e le poesie vengono al mondo per resistere. È l’ascesa della voce in libertà e la speranza che cada un dogma, un modello che ci condanna alla disuguaglianza.
Bisogna vedere lo spasmo sul volto del poeta e ricordare le sue parole: “Perché alla fine, ciò che emoziona di un uomo non sono i suoi sentimenti ma il suo rictus, quei movimenti quasi impercettibili che a poco a poco si vanno stampando agli angoli delle labbra, sulle palpebre o sul semplice contrarsi delle sopracciglia, e che non si rassegnano a morire con le nostre facce che muoiono”. No, non si rassegnano a morire con le nostre facce, con facce come la sua che è stata la tela di poesie radicali, scritte da lui stesso con ammoniaca e ferro rovente (“volevo esprimere l’impotenza di fronte alla realtà e il bisogno di dire senza parole”, ha spiegato). Zurita ha scritto anche nel cielo (lo ha fatto sempre) e sul volto del deserto ha plasmato queste quattro parole: “NI PENA NI MIEDO” (né dolore né paura). Oggi la sua figura dice tutto senza parole, senza dolore e senza paura. E quello che dice è che c’è un profondo malessere tra la gente, che non si deve produrre ricchezza a qualsiasi prezzo, che non c’è un senso di appartenenza tra i giovani, che la concentrazione dei patrimoni è oscena, che si deve reinventare l’idea di comunità, diversa e solidale, che la élite abita in un altro pianeta e che i governi non comunicano con la gente. Dice disuguaglianza, dice assenza di mobilità sociale. Dice che il nostro modello economico si sta distruggendo da solo. Zurita ne sa qualcosa di quei punti di svolta. La sua opera è un movimento che va dal Purgatorio all’Antiparadiso, da lì alla Vita Nova, e che sbocca in Zurita, che è tutti ed è nessuno. È un’opera scritta con amore, amore rudimentale, amore per il Cile e per i suoi simili: “La furia dell’amore che colpisce le pietre, quella che ha scolpito le cordigliere, il mare e il desiderio umano”. Il suo sguardo è a tutto tondo, dai grandi tratti, “come se nei paesaggi fosse contenuta una redenzione infinitamente più vasta dell’umano, un conforto, una speranza tanto travolgente ed enorme da poter appartenere solo ai cataclismi o al delirio”. Questo è l’uomo che è sceso in strada come tutti, a protestare, a dire basta. Questo è l’uomo che ha scritto la poesia “Cari potenti, cari umili”. Sono otto versi che parlano per noi:
Quando tutto sarà finito forse resteranno
queste alghe
sopravviveranno alle mareggiate, ai secoli
e ai sogni.
Come perdureranno ai potenti
ai duri di cuore
e agli uomini che ci umiliano
queste poesie d’amore per tutte le cose.
*******************************************
Metto qui anche il link dei pezzo appena composto ed eseguito dai Noise Of Trouble (miei compagni di strada e fratelli sempre presenti dove c’è da resistere).